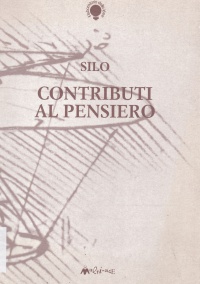Contributi al Pensiero: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 96: | Riga 96: | ||
''Contribucciones al Pensamiento'' viene pubblicato in Argentina per la prima volta nel 1990 | ''Contribucciones al Pensamiento'' viene pubblicato in Argentina per la prima volta in Argentina nel 1990 dalla Casa Editrice Planeta. Ne esistono poi edizioni in lingua originale curate da Plaza y Valdés in Messico (1990), da Virtual Edicciones in Cile (2013) e da Ediciones León Alado Spagna (2013), Editorial Beta Hydri, Bolivia (2013). | ||
Il libro è pubblicato in catalano da Ediciones León Alado (2013), in russo da Vesna (2015) e in tedesco da Uzielli Verlag (1995) | |||
= Traduzioni = | = Traduzioni = | ||
Versione delle 12:17, 26 lug 2022
Libro di Silo composto da due saggi filosofici: Psicologia dell’immagine e Discussioni storiologiche; incluso nel Volume I delle Opere Complete.
Spiegazione
Contributi al pensiero è composto di due saggi.
Il primo, Psicologia dell’immagine, è stato scritto nel 1988, mentre il secondo, Discussioni storiologiche, è stato terminato nel 1989. Sebbene si riferiscano a campi diversi, i due testi sono in stretta relazione e, in un certo senso, si chiariscono a vicenda. Per questo la loro pubblicazione congiunta con il titolo di Contributi al pensiero ci è sembrata opportuna. I punti di vista espressi in Psicologia dell’immagine e in Discussioni storiologiche sono caratteristici della riflessione filosofica e non sorgono dalle matrici della psicologia e della storiografia. Tuttavia, entrambi i lavori hanno per oggetto i fondamenti stessi di queste discipline.
In Psicologia dell’immagine, l’autore presenta una teoria innovativa su quello che chiama “spazio di rappresentazione”, “spazio” che sorge quando si mettono in evidenza gli oggetti della rappresentazione (non semplicemente quelli della percezione) e senza il quale non si può comprendere come la coscienza possa orientarsi e distinguere tra il “mondo esterno” e il “mondo interno”. In effetti, se la percezione presenta i fenomeni a chi li percepisce, in quale luogo questi si colloca rispetto ad essi? Se si risponde dicendo che si colloca nella spazialità esterna, in accordo con l’“esteriorità” del fenomeno percepito, allora come può tale soggetto muovere il corpo dall’“interno” guidandolo in tale “esteriorità”? Grazie alla percezione si può spiegare come il dato giunga alla coscienza ma non si può giustificare il movimento che la coscienza imprime al corpo. Può il corpo agire nel mondo esterno se non esiste una rappresentazione di entrambi questi termini, corpo e mondo? Ovviamente no. Pertanto, tale rappresentazione deve sorgere in qualche “luogo” della coscienza. Ma in che senso si può parlare di “luogo”, “colore” o “estensione” nella coscienza? Queste sono alcune delle difficoltà affrontate e risolte nel presente saggio, il cui obiettivo è di dimostrare le seguenti tesi: 1. L’immagine è un modo attivo di porsi nel mondo da parte della coscienza e non semplice passività, come hanno sostenuto le teorie precedenti. 2. Questo modo attivo non può essere indipendente da una “spazialità” interna. 3. Le numerose funzioni svolte dall’immagine dipendono dalla posizione da essa assunta in tale “spazialità”.
Se ciò che l’autore sostiene è corretto, i fondamenti dell’agire umano dovranno subire una profonda revisione. Non sarà più possibile sostenere che siano le idee, o la “volontà” oppure la “necessità oggettiva” a far muovere il corpo e a dirigerlo verso le cose; bisognerà ammettere che sono invece le immagini e la collocazione da esse assunta nello spazio di rappresentazione. Le idee o la “necessità oggettiva” potranno orientare l’attività nella misura in cui si disporranno come immagini e, nella prospettiva della rappresentazione, nella misura in cui si colloccheranno in un paesaggio interno adeguato. Ma questa possibilità non sarà propria solo della necessità o delle idee: apparterrà anche alle credenze e alle emozioni trasformate in immagini. Le conseguenze che derivano da tali tesi sono enormi, e l’autore stesso sembra suggerirne la portata con le parole che pone a chiusura del lavoro: “Se le immagini permettono di riconoscere e di agire, gli individui e i popoli tenderanno a trasformare il mondo in modi diversi a seconda della struttura del loro paesaggio e delle loro necessità (o di ciò che considerano le loro necessità).”
In Discussioni storiologiche si passano in rassegna le diverse concezioni che l’autore riunisce sotto la designazione unica di “storia senza temporalità”. Come mai fino a oggi nello studio della storia umana l’uomo è stato sempre considerato come un epifenomeno del mondo naturale o come una “semplice cinghia di trasmissione di fattori a lui esterni, dei quali è solo paziente”? A quali ragioni si deve la mancanza di spiegazioni adeguate sulla natura della temporalità? L’autore afferma che la Storiologia diventerà scienza solo nella misura in cui risponderà a tali domande e chiarirà i prerequisiti necessari ad ogni discorso storico, ovvero che cosa si debba intendere per storicità e per temporalità. Nella Premessa a quest’opera si dice: “Abbiamo fissato come obiettivo del nostro lavoro il chiarimento dei requisiti preliminari necessari per dare fondamento alla Storiologia. E’ evidente che disporre di un sapere cronologico sugli avvenimenti storici non è ragione sufficiente per avanzare pretese di scientificità...”
La Storiologia non può prescindere dalla comprensione della struttura della vita umana, poiché lo storiologo, anche se volesse fare semplice storia naturale, si vedrebbe costretto a strutturare tale storia naturale utilizzando un’ottica ed un’interpretazione umana. Ma la vita umana è proprio storicità, temporalità, ed è appunto nella comprensione della temporalità che sta la chiave di ogni costruzione storica. Ma allora, che cosa determina gli avvenimenti umani, secondo quali modalità essi si succedono? L’autore risponde che sono le generazioni, con le loro diverse accumulazioni temporali, gli agenti di qualunque processo storico; sebbene coesistano in uno stesso momento, le generazioni possiedono differenti paesaggi di formazione, di sviluppo e di lotta proprio perché le une sono nate prima delle altre. Il bambino e il vecchio, per esempio, vivono apparentemente in uno stesso tempo storico, ma, pur coesistendo, rappresentano paesaggi e accumulazioni temporali diverse. Certo, le generazioni nascono l’una dall’altra in un continuum biologico, ma ciò che le caratterizza è la costituzione sociale e temporale, che è diversa per ciascuna di esse.
Conferenza dell'Autore
Trascriviamo la conferenza data al Centro Culturale San Martin a Buenos Aires il 4 Ottobre 1990, inclusa in Discorsi
Commentare un libro come Contributi al pensiero, appena pubblicato, sembrerebbe implicare l’utilizzo di un linguaggio alquanto tecnico; ma pur se il presente materiale richiedesse di essere trattato in questo modo, è bene chiarire subito che in questa presentazione cercheremo di mettere in risalto i nodi principali dello scritto senza dar prova di un eccessivo rigore terminologico. La presentazione stessa, poi, sarà piuttosto breve.
Questo libro, come sappiamo, si compone di due saggi riguardanti concetti generali che apparentemente si inquadrano all’interno della psicologia e della storiografia, come rivelano i rispettivi titoli: Psicologia dell’immagine e Discussioni storiologiche. Ma risulterà subito chiaro come ambedue gli studi si intreccino e puntino ad uno stesso obiettivo, che è quello di gettare le basi per la costruzione di una teoria generale dell’azione umana, teoria che attualmente non risulta fondata in modo adeguato. Quando parliamo di una teoria dell’azione non ci riferiamo solo alla comprensione del lavoro umano come fanno la prassologia di Kotarbinski, Skolimowski od in generale della scuola polacca, che ha giustamente il merito di avere approfondito questo argomento; il nostro interesse è volto invece alla comprensione dei fenomeni che riguardano l’origine, il significato ed il senso dell’azione. Ovviamente si potrà obiettare che l’azione umana non ha bisogno di alcuna giustificazione teorica, che l’azione si trova agli antipodi della teoria, che le necessità del momento sono prevalentemente pratiche, che l’azione si misura in termini di risultati concreti e che, infine, non è questo il momento per teorie o ideologie, visto che il loro fallimento e il loro crollo definitivo risulta ormai dimostrato e che grazie a questo la realtà concreta trova finalmente il cammino sgombro, cammino che deve condurre alla scelta delle circostanze più adeguate per il perseguimento dell’azione efficace.
Le obiezioni precedenti, per quanto vaghe e confuse, rivelano tutte un indubbio fondo di pragmatismo; e questo, come sappiamo, si manifesta nella vita di tutti i giorni come un’attività anti-ideologica le cui argomentazioni si appoggiano su una supposta realtà fattica. Ma i difensori di tale atteggiamento non ci dicono nulla su che cosa sia la realtà a cui fanno riferimento né quali siano i parametri entro i quali deve collocarsi l’azione per poter essere considerata “efficace”. Perché se il concetto di “realtà” viene, con una grossolana riduzione, identificato con ciò che ci sembra di percepire attraverso i sensi, si rimane prigionieri della superstizione che la scienza smentisce ad ogni passo del suo sviluppo. Se poi si menziona l’“efficacia dell’azione” sarà opportuno stabilire, come minimo, se l’ipotetico esito di questa si misuri in termini immediati, se cioè l’azione si concluda nel “fatto” oppure se essa produca delle conseguenze che continuano a svilupparsi anche dopo tale conclusione. Se si dà per valida la prima ipotesi, non risulta possibile comprendere come le azioni possano collegarsi tra di loro, per cui si lascia il campo libero a qualunque incoerenza od alla possibile contraddizione fra l’azione di un momento B rispetto all’azione del momento A. Se invece si ammette che esistano conseguenze a più largo raggio dell’azione, ne deriva che questa potrà avere successo in un momento A e non averlo più in un momento B. Per contestare una simile ideologia, che pretende di non essere tale, ci siamo visti obbligati ad effettuare questa digressione, anche a rischio di una caduta del livello espositivo. Sebbene i suoi argomenti abbiano scarso valore, tale ideologia si è affermata con una certa forza, diventando quasi un modo di pensare comune, e questo provoca reazioni sfavorevoli nei confronti di qualunque proposta del tipo della nostra.
Noi, al contrario, apprezziamo il valore delle formulazioni teoriche sul problema dell’azione e collochiamo la nostra concezione tra le posizioni ideologiche, intendendo per “ideologia” ogni pensiero, scientifico o meno, che si articoli in un sistema di interpretazioni di una determinata realtà. Utilizzando poi un’altra prospettiva, rivendichiamo una totale indipendenza dalle teorie nate nel secolo scorso, teorie il cui fallimento, non solo pratico ma soprattutto teorico, risulta ormai dimostrato. Il crollo delle ideologie del XIX secolo, quindi, nulla toglie alle nuove concezioni oggi in gestazione, se mai il contrario. Diciamo inoltre che sia “La Fine delle Ideologie”, preconizzata da Daniel Bell negli anni sessanta, sia “La Fine della Storia”, annunciata da poco da Fukuyama, rispondono ad una concezione antiquata, perché tendono a chiudere un dibattito che in termini ideologici si era già esaurito negli anni cinquanta, ovviamente molto prima che alcuni spettacolari eventi politici di questi anni facessero sobbalzare coloro che avevano avvertito in ritardo il passo della storia, ipnotizzati com’erano dalle loro teorie sul successo pratico. Questo pragmatismo invecchiato, le cui origini risalgono all’incirca al 1870, al Metaphysical Club di Boston, e che James e Peirce hanno esposto con la mediocrità intellettuale che li caratterizzava, è fallito già da molto tempo anche in termini ideologici. Ora ci rimane solo da vedere le cose spettacolari che metteranno fine alle teorie sulla “Fine della Storia” e sulla “Fine delle Ideologie”.
Chiarito che l’obiettivo del libro è quello di gettare le basi per la costruzione di una teoria generale dell’azione umana, andiamo ai punti più importanti del primo lavoro, intitolato Psicologia dell’immagine. In esso si cerca di dare fondamento alla seguente ipotesi: la coscienza non è prodotto né riflesso dell’azione dell’ambiente; al contrario, assumendo le condizioni che l’ambiente le impone, essa finisce per costruire un’immagine od un insieme di immagini capace di promuovere l’azione nel mondo e pertanto di modificarlo. Il produttore dell’azione si modifica con questa; tale continuo processo di retroalimentazione mette in evidenza una struttura soggetto-mondo e non due termini separati che occasionalmente interagiscono. Pertanto, pur parlando di “coscienza” seguendo in modo generico l’approccio psicologico che il tema dell’immagine impone, intendiamo per coscienza il momento dell’interiorità nell’apertura della vita umana nel-mondo. Quindi il termine “coscienza” deve essere compreso nel contesto dell’esistenza concreta e non separato da questa, come sono solite fare le diverse correnti psicologiste.
Nel lavoro che stiamo commentando un punto importante sta nel mettere in luce il rapporto tra i fenomeni della rappresentazione e la spazialità, proprio poiché grazie a questo rapporto il corpo umano può spostarsi e, più in generale, agire nel mondo nel modo che gli è proprio. Se la teoria dei riflessi si fosse dimostrata adeguata, avremmo risolto il problema almeno in parte; invece il fenomeno della risposta differita, del ritardo nel rispondere agli stimoli richiede un sistema esplicativo più ampio. E se poi parliamo di elaborazioni grazie alle quali il soggetto giunge alla conclusione di agire secondo una direzione specifica tra varie possibili, il concetto di riflesso si diluisce tanto che finisce per non spiegare più nulla.
Sul tema della coscienza trasformata in comportamento abbiamo cercato dei precedenti e così ci siamo imbattuti in vari studiosi e pensatori tra i quali spicca Descartes; in una singolare lettera inviata a Cristina di Svezia, questi parla del punto di unione tra pensiero e mobilità del corpo. Quasi trecento anni dopo Brentano introduce in psicologia il concetto di intenzionalità, che a suo tempo la scolastica aveva messo in evidenza e rivalutato nei suoi commenti ad Aristotele. Ma è con Husserl che lo studio dell’intenzionalità si fa esauriente, particolarmente in Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia fenomenologica. Mettendo in discussione i dati del mondo esterno ed anche quelli del mondo interno, secondo la migliore tradizione della riflessione, questo autore apre la strada all’indipendenza del pensare nei confronti della materialità dei fenomeni, un pensare fino a quel momento stretto nella tenaglia dell’idealismo assoluto hegeliano, da un lato, e delle scienze fisico-naturali, allora in rapido sviluppo, dall’altro. Husserl non si fermerà al semplice studio del dato iletico, materiale, ma effettuerà una riduzione eidetica, dalla quale non si potrà più tornare indietro. Se ci si riferisce alla spazialità della rappresentazione in generale, bisognerà ormai considerarla come una forma, i cui contenuti non possono essere indipendenti l’uno dall’altro. In un altro livello di spiegazione, Husserl dimostrerà che il colore in tutte le immagini visive non è indipendente dall’estensione. Questo punto è di importanza fondamentale perché pone la forma dell’estensione come condizione di tutte le rappresentazioni. Noi prenderemo questa asserzione come la base teorica su cui formulare l’ipotesi dello spazio di rappresentazione.
In ogni modo, quanto detto fin qui ha bisogno di alcune spiegazioni aggiuntive che presenteremo in modo molto sintetico. In primo luogo, definiremo la sensazione come il vissuto che si ottiene captando uno stimolo proveniente dall’ambiente esterno od interno, stimolo che fa variare il tono di lavoro del senso colpito. Inoltre intenderemo la percezione come una strutturazione di sensazioni compiuta dalla coscienza, strutturazione che si riferisce ad un singolo senso o ad un insieme di sensi. Certo, sappiamo bene che anche nella sensazione più elementare esiste un fenomeno di strutturazione ma concedendo alla psicologia classica una certa prossimità al nostro modo di presentare l’argomento, non discuteremo più di tanto le definizioni precedenti. Intenderemo, infine, l’immagine come una ri-presentazione strutturata e formalizzata di sensazioni o di percezioni provenienti o pervenute dall’ambiente esterno od interno, la quale, proprio in ragione di questa strutturazione, non può essere considerata semplice “copia” passiva delle sensazioni, come ha creduto la psicologia ingenua.
Dopo aver discusso e rigettato le tesi della psicologia atomistica, siamo giunti alla conclusione che tanto le sensazioni che le percezioni e le immagini siano forme di coscienza e che pertanto sarebbe più corretto parlare di “coscienza della sensazione, coscienza della percezione e coscienza dell’immagine”, senza per questo doversi necessariamente collocare in un atteggiamento appercettivo. Ciò che qui si vuole dire è che la coscienza modifica il proprio modo di essere, anzi che essa non è altro che un modo di “essere”, per esempio essere “emozionata”, “in attesa”, ecc. Sulla base dell’idea di intenzionalità, risulta chiaro che non c’è coscienza se non di qualcosa e che quel “qualcosa” non può sfuggire alla spazializzazione del rappresentare. Siccome ogni rappresentare in quanto atto di coscienza si riferisce ad un oggetto rappresentato e siccome i due termini non possono essere separati in quanto formano una struttura, ne consegue che il fatto di rappresentare un qualsiasi oggetto coinvolge il corrispondente atto di coscienza nella spazialità di tale oggetto. E per quanti esperimenti si facciano, utilizzando o rappresentazioni esterne, che hanno per base i cinque sensi classici, o rappresentazioni interne, che hanno origine nella cenestesi o nella cinestesi, si finirà sempre per spazializzare.
D’altra parte, se la spazialità della sensazione e quella della percezione si riferiscono a “luoghi” del corpo nei quali si trovano i rilevatori sensoriali, lo stesso deve valere per le rappresentazioni corrispondenti. Rappresentare, per esempio, un mal di denti che oggi non esiste più significa cercare di “ricrearlo” in un punto preciso del cavo orale e non in una gamba. Questo è chiaro, ed è valido per tutte le rappresentazioni. Ma qui sorge uno dei problemi più interessanti. L’immagine può modificarsi a tal punto che, nel ricrearlo, può addirittura rendere irriconoscibile l’oggetto originario. E questa capacità di “deformazione” è stata considerata dalla psicologia ingenua come uno dei difetti fondamentali dell’immagine. L’idea era chiara: se l’immagine era solo una copia della sensazione, la cui funzione stava nel permettere alla memoria di ricordare, se essa era solo uno strumento di ciò che veniva chiamato “facoltà della memoria”, qualunque deformazione costituiva quasi un “peccato contro natura”, peccato che gli psichiatri dell’epoca tentavano di sradicare con i loro energici trattamenti da quei poveri disgraziati che esageravano nell’alterare la realtà. Ma, battute a parte, è evidente che il naturalismo aveva invaso, e non poteva essere altrimenti, la psicologia proprio come aveva invaso l’arte, la politica e l’economia. Ma è proprio questo “difetto”, che le permette di deformarsi, di trasformarsi e perfino di trasferirsi (come nei sogni) da una fonte sensoriale ad un’altra, a mostrare non solo la plasticità ma anche la straordinaria gamma di attività dell’immagine.
E’ facile comprendere come uno sviluppo adeguato di ciascuna delle precedenti affermazioni ci porterebbe oltre i limiti di questa conferenza; pertanto, seguendo l’idea iniziale, qui ci occuperemo di presentare solo gli aspetti nodali della ricerca. Fra di essi c’è quello in cui si mostra come l’immagine agisca in diversi livelli di coscienza e produca differenti abreazioni motorie a seconda della sua “interiorizzazione” o “esteriorizzazione”. Per verificare ciò si osservi come un’immagine che comporta l’estensione della mano in veglia non sia in grado di muovere tale arto quando viene interiorizzata nel sogno, salvo casi eccezionali di sogno alterato o di sonnambulismo, nei quali l’immagine tende ad esteriorizzarsi nello spazio di rappresentazione. Ma anche in veglia un forte shock emotivo può far sì che, in certi casi, l’immagine di fuga o di repulsione si interiorizzi a tal punto da paralizzare il corpo. Il fenomeno contrario accade negli stati alterati di coscienza in cui la proiezione all’esterno delle immagini (le allucinazioni) pone il corpo in attività; ma tali immagini si riferiscono a fonti sensoriali la cui collocazione risulta confusa giacché traducono rielaborazioni del mondo interno. Pertanto è la diversa collocazione dell’immagine (in livello e in profondità) nello spazio di rappresentazione a far scattare in modo diverso l’attività corporea. Ma è opportuno ricordare che stiamo parlando di immagini alla cui base stanno differenti gruppi di sensi, esterni od interni; in effetti le immagini cenestesiche, se operanti nella profondità e nella collocazione che ad esse corrisponde, provocheranno abreazioni o somatizzazioni nell’intracorpo, mentre le immagini relative al sistema cinestetico saranno quelle che alla fine agiranno sul corpo “dall’interno” per metterlo in movimento. Ma come e verso dove si muoverà il corpo, visto che la cinestesi è legata a fenomeni interni? Si muoverà seguendo la direzione “tracciata” da altre rappresentazioni, che hanno nei sensi esterni la propria base sensoriale. Considerando il fenomeno al contrario, il mio braccio non si muoverà per il solo fatto di immaginarlo disteso in avanti, come posso facilmente constatare; immaginarlo disteso in avanti significa tracciare la direzione del movimento (come prova il concomitante cambiamento del tono muscolare) ma il braccio si muoverà solo quando l’immagine visiva si sarà tradotta in cinestetica.
Ma andiamo avanti. Ora daremo un rapido sguardo al tema della natura dello spazio di rappresentazione ed ai concetti di compresenza, orizzonte e paesaggio nel sistema di rappresentazione. Non aggiungeremo, però, niente di nuovo rispetto a quanto detto nei Paragrafi 3 e 4 del Capitolo III di Psicologia dell’immagine (salvo per ciò che si riferisce alla conclusione di tale lavoro).
Non abbiamo parlato di uno spazio di rappresentazione in sé né di un quasi-spazio mentale. Abbiamo detto che la rappresentazione in quanto tale non può rendersi indipendente dalla spazialità; ma con questo non abbiamo affermato che la rappresentazione occupi uno spazio. E’ la forma della rappresentazione spaziale ciò che prendiamo in considerazione. Stando così le cose, se parliamo di “spazio di rappresentazione” senza riferirci ad una rappresentazione specifica, è perché stiamo considerando l’insieme delle percezioni e immagini (non visive) che danno l’esperienza vissuta ed il tono corporeo e di coscienza nel quale mi riconosco come “io”, nel quale mi riconosco come un “continuo”, nonostante il fluire e il cambiamento che vado sperimentando. Quindi, lo “spazio di rappresentazione” è tale non perché sia un contenitore vuoto che debba essere riempito da fenomeni di coscienza, ma perché la sua natura è rappresentazione, per cui, quando sorgono determinate immagini, la coscienza non può fare altro che presentarle sotto la forma dell’estensione. In modo analogo, avremmo potuto insistere sull’aspetto materiale della cosa rappresentata, riferendoci alla sostanzialità, senza per questo parlare dell’immagine nel senso in cui si esprimono la fisica o la chimica. Ci saremmo riferiti, in quel caso, ai dati iletici, ai dati materiali che non sono la materialità stessa. E, ovviamente, a nessuno verrebbe in mente che la coscienza abbia un colore o che sia un contenitore colorato per il fatto che le rappresentazioni visive si presentano colorate. Ma nonostante tutto, sussiste una difficoltà. Quando diciamo che lo spazio di rappresentazione ha diversi livelli e profondità, è perché stiamo parlando di uno spazio volumetrico, tridimensionale, oppure perché la struttura percettivo-rappresentativa della mia cenestesi mi si presenta volumetricamente? E’ vera, senza alcun dubbio, la seconda alternativa; ed è per questo che le rappresentazioni possono apparire in alto o in basso, a sinistra o a destra e avanti o indietro, e che anche lo “sguardo” si colloca, rispetto all’immagine, in una prospettiva determinata.
... Possiamo considerare lo spazio di rappresentazione come la “scena” nella quale si svolge la rappresentazione e dalla quale abbiamo escluso lo “sguardo”. Ed è chiaro che in una “scena” si sviluppa una struttura di immagini che deriva o è derivata da numerose fonti percettive e da percezioni di immagini precedenti.
Per ciascuna struttura di rappresentazione esiste un’infinità di alternative che non si manifestano totalmente ma che agiscono in compresenza, mentre la rappresentazione stessa si manifesta in “scena”. E’ ovvio che qui non ci stiamo occupando di contenuti “manifesti” o “latenti” né di “vie associative” che possono imprimere alle immagini direzioni diverse.
Spieghiamo questo punto con un esempio: quando immagino un oggetto della mia stanza, esso è accompagnato in compresenza da altri oggetti che fanno parte dello stesso ambito ma che non appaiono in “scena”; ed è proprio grazie al fatto che tale ambito o regione include anche oggetti non presenti, oltre a quelli presenti, che io posso far apparire a volontà gli uni e gli altri, sempre però all’interno dei limiti di ciò che indico come “la mia stanza”. Analogamente, anche le regioni si strutturano le une con le altre e non solo come insiemi di immagini ma anche come insiemi di espressioni, significati e relazioni. Posso distinguere ciascuna regione - od insieme di regioni - dalle altre grazie agli “orizzonti”, che sono una sorta di limiti, i quali mi permettono di ubicarmi mentalmente ed anche di spostarmi in diversi tempi e spazi mentali.
Quando percepisco il mondo esterno, quando nella vita quotidiana mi muovo in esso, non lo costituisco solo attraverso le rappresentazioni che mi permettono di riconoscere ed agire, ma lo costituisco anche attraverso sistemi compresenti di rappresentazione. Se a questa strutturazione del mondo da me effettuata dò il nome di “paesaggio”, mi risulta immediatamente verificabile come la percezione del mondo sia sempre riconoscimento e interpretazione di una realtà sulla base del mio paesaggio. Questo mondo che prendo per la realtà stessa è la mia propria biografia in azione e l’opera di trasformazione che svolgo nel mondo è la mia stessa trasformazione. E quando parlo del mio mondo interno, parlo anche dell’interpretazione che ne sto dando e della trasformazione che vi opero.
Le distinzioni fin qui adottate fra spazio “interno” e spazio “esterno” sulla base dei vissuti di limite riconducibili alle percezioni cenestesico-tattili non possono essere mantenute quando parliamo di questo modo globale di stare nel mondo caratteristico della coscienza, secondo cui il mondo è il “paesaggio” della coscienza e l’io il suo “sguardo”. Il modo di stare nel mondo proprio della coscienza è fondamentalmente un modo di azione in prospettiva, che ha nel corpo - e non solo nell’intracorpo- il proprio riferimento spaziale. Ma il corpo, nell’essere oggetto del mondo, è anche oggetto del paesaggio e quindi oggetto di trasformazione. Il corpo finisce allora per diventare una protesi dell’intenzionalità umana.
Se le immagini permettono di riconoscere e di agire, allora individui e popoli tenderanno a trasformare il mondo in modi diversi a seconda della struttura del loro paesaggio e delle loro necessità (o di ciò che considerino le loro necessità). Per concludere queste osservazioni su Psicologia dell’immagine, aggiungerò che nella configurazione di qualunque paesaggio agiscono in compresenza contenuti tetici, che sono una sorta di credenze o di relazioni fra credenze che non possono essere sostenute razionalmente. Essi, dato che accompagnano qualunque formulazione ed azione, costituiscono la base su cui si fonda la vita umana nel suo svolgersi quotidiano.
Da quanto detto una futura teoria dell’azione dovrà spiegare come questa sia possibile fin dalle sue espressioni più elementari; essa dovrà anche rendere conto di come l’attività dell’essere umano non sia semplice riflesso di condizioni esistenti e di come l’azione, trasformando il mondo, trasformi in pari tempo il suo produttore. Le conclusioni a cui tale teoria giungerà non saranno indifferenti, come non lo saranno le direzioni che verranno prese; e questo non solo per il futuro sviluppo dell’etica ma per la possibilità stessa di un progresso dell’umanità.
Passiamo ora a commentare rapidamente il secondo saggio del presente libro.
Discussioni storiologiche intende studiare i requisiti preliminari necessari per dare fondamento a ciò che chiamiamo “Storiologia”. Già all’inizio della discussione si mette in dubbio che le definizioni di “Storiografia” o “filosofia della storia” possano continuare a essere utili ancora per molto, essendo state impiegate con significati tanto diversi che è ormai molto difficile giungere ad una determinazione dell’oggetto a cui si riferiscono. Il termine “Storiologia” è stato coniato da Ortega intorno al 1928, in uno scritto intitolato La Filosofia della storia di Hegel e la storiologia. In una nota del nostro saggio viene citato il seguente brano tratto dallo scritto di Ortega: “Nella storiografia e nella filologia attuali è inaccettabile il dislivello esistente tra la precisione con cui si raccolgono o si trattano i dati, e l’imprecisione, o meglio, la miseria intellettuale nell’uso delle idee costruttive. Contro questo stato di cose nel regno della storia s’innalza la storiologia. Mossa dalla convinzione che la storia, come ogni scienza empirica, debba essere prima di tutto una costruzione e non un ‘ammasso’. [...] La centesima parte dei dati già raccolti e depurati bastava già per elaborare qualcosa di una portata scientifica molto più autentica e sostanziosa di quanto, in effetti, ci presentino i libri di storia”. Sulla scia di questo dibattito iniziato molto tempo fa, nel nostro saggio si parla di Storiologia nel senso di un’interpretazione e nel senso della costruzione di una teoria coerente, nella quale i dati storici in sé non possano essere giustapposti o organizzati in guisa di una semplice “cronaca” di avvenimenti, con il rischio di svuotare il fatto storico di ogni significato. La pretesa di una Storia (con tanto di maiuscola) estranea ad ogni interpretazione è un controsenso che ha reso vani numerosi sforzi della storiografia precedente.
In questo lavoro si studia, da Erodoto in avanti, la visione del fatto storico sotto un’angolatura specifica, quella dell’introduzione del paesaggio dello storico nella descrizione. Procedendo in questo modo, si riescono a cogliere non meno di quattro deformazioni dell’ottica storica. In primo luogo, l’introduzione intenzionale, da parte dello storico, del momento in cui vive per dare risalto ad alcuni fatti o minimizzare l’importanza di altri secondo la propria prospettiva. Questa deformazione è osservabile nella presentazione del racconto ed influisce tanto sulla trasmissione del fatto quanto su quella del mito, leggenda, tema religioso o letterario che sono serviti da fonte. La seconda deformazione consiste nella manipolazione delle fonti; trattandosi di una frode, essa non merita commenti. La terza riguarda la semplificazione e la stereotipia che consentono di dare valore - od al contrario di squalificare - dei fatti sulla base di un modello più o meno accettato. La mancanza di impegno che caratterizza sia gli autori sia i lettori di queste opere è tale che esse in genere risultano avere una grande diffusione nonostante lo scarso valore scientifico. In lavori di questo tipo l’informazione attendibile è spesso sostituita da “storie”, “dicerie” od informazioni di seconda mano. La quarta deformazione che rileviamo si riferisce invece alla “censura”, che a volte si trova non solo nella penna dello storico ma anche nella testa del lettore. La censura impedisce che nuovi punti di vista si diffondano correttamente; essa opera perché è il momento storico stesso, con il suo repertorio di credenze, a formare una barriera che solo il tempo, o meglio, avvenimenti drammatici che smentiscono ciò che è comunemente accettato, permetteranno di abbattere.
Fin qui le Discussioni hanno messo in evidenza, in modo generale, quali difficoltà si presentino nella valutazione dei fatti mediati. Ma ben più sconcertante risulta il verificare come un soggetto riferisca cose inesistenti o decisamente deformate anche quando racconta a se stesso o ad altri avvenimenti della sua storia immediata, cioè della propria storia personale, biografica; e che lo faccia, in sovrappiù, all’interno di un ineludibile sistema interpretativo. Ma allora, se le cose stanno così, che succederà quando si ha a che fare con eventi che non sono stati vissuti dallo storico ma che fanno parte di ciò che chiamiamo “storia mediata”? In ogni modo queste considerazioni non ci portano necessariamente allo scetticismo storico e questo perché fin dall’inizio abbiamo riconosciuto la necessità che la Storiologia sia costruttiva e che, ovviamente, rispetti certe condizioni per essere considerata una scienza completa.
Le Discussioni proseguono prendendo in esame ciò che chiamiamo “concezioni della storia senza il fondamento temporale”. Nel Capitolo II, Paragrafo 1 del nostro lavoro, facciamo questa osservazione: “Nei numerosi sistemi in cui appare un rudimento di Storiologia, tutto lo sforzo sembra diretto a giustificare la databilità, il momento di calendario accettato, analizzando nei minimi dettagli come accaddero, perché accaddero, o come sarebbero dovute accadere le cose; mai però si prende in considerazione cosa sia l’“accadere”, come sia possibile, in generale, che qualcosa accada.”
Tutti coloro che si sono dedicati a costruire delle vere e proprie cattedrali di Filosofia della Storia, nella misura in cui non hanno risposto alla domanda fondamentale sulla natura dell’accadere, ci hanno presentato solo una Storia della databilità civile accettata, priva della dimensione della temporalità, che è necessaria proprio perché quella sia appresa. In termini generali osserviamo che il concetto di tempo che ha prevalso finora è quello tipico della percezione ingenua, per la quale i fatti si svolgono senza strutturalità e si succedono, dall’anteriore al posteriore, secondo una sequenza lineare; per la quale gli eventi stanno “uno accanto all’altro”, senza che sia possibile comprendere come un momento diventi un altro momento, senza che sia possibile cogliere, insomma, l’intima trasformazione dei fatti. Perché dire che un avvenimento va da un momento A ad un momento B e così via fino a un momento N - da un passato attraverso un presente per proiettarsi verso un futuro - significa solo parlare della collocazione dell’osservatore in un tempo di databilità convenzionale, mettendo in risalto la percezione del tempo propria dello storico e, appunto perché si tratta di percezione, spazializzando il tempo tra un “indietro” ed un “avanti” nel modo in cui lo spazializzano le lancette dell’orologio per mostrare che esso trascorre. Comprendere ciò non presenta difficoltà, una volta acquisita la consapevolezza che ogni percezione ed ogni rappresentazione si danno sotto forma di “spazio”. Ma perché mai il tempo dovrebbe trascorrere da un “indietro” ad un “avanti ”e non, per esempio, in senso inverso o a “salti” imprevedibili? Non si può rispondere a questa domanda con un semplice “perché è così”. Ammettendo che ogni “ora” è, “da ambo i lati”, successione indeterminata di istanti, si giunge alla conclusione che il tempo è infinito; ma accettare questa supposta “realtà” significa anche allontanare lo sguardo dalla propria finitezza e passare così attraverso la vita in presenza della convinzione che il fare tra le cose sia infinito, anche se “in compresenza” si sa che la vita ha una fine. In questo modo “le cose che si hanno da fare” eludono la morte di ogni istante; per questo “si ha più o meno tempo per determinate cose”; infatti l’“avere” si riferisce alle “cose” per cui il trascorrere stesso della vita si trasforma in cosa, si naturalizza.
La concezione naturalistica del tempo che ha pervaso fino a oggi la Storiografia e la Filosofia della Storia si fonda sulla credenza nella passività dell’essere umano nella costruzione del tempo storico; su questa base si è arrivati a considerare la storia umana come un “riflesso” o come una sorta di “cinghia di trasmissione” degli eventi naturali o come un epifenomeno della storia naturale. Ed anche quando, con un salto ingiustificato dal mondo naturale a quello sociale, gli insiemi umani sono stati considerati come i generatori dei fatti storici, il naturalismo non è stato affatto abbandonato e la visione ingenua del tempo ha prodotto una “spazializzazione” della società.
Un pensiero rigorosamente riflessivo ci porta a comprendere come in tutto il fare umano i tempi non si succedano “naturalmente” ma come gli istanti passati, presenti e futuri agiscano in modo strutturale: ciò che è accaduto in quanto memoria e conoscenza risulta infatti tanto determinante quanto i progetti che si tenta di rendere operanti attraverso azioni nel presente. Il fatto che l’essere umano non possegga una “natura” allo stesso modo in cui qualsiasi altro oggetto la possiede, il fatto che tenda intenzionalmente a superare le determinazioni naturali ne mostra la radicale storicità. L’essere umano si costituisce e si costruisce attraverso l’azione-nel-mondo ed è in questo modo che dà un senso al proprio trascorrere ed al fatto assurdo di una natura priva di intenzionalità. La finitezza, in termini di tempo e spazio, si presenta come prima condizione assurda, senza senso, che la natura impone alla vita umana attraverso precise esperienze vissute di dolore e sofferenza. La lotta contro quest’assurdità, il superamento del dolore e della sofferenza è ciò che dà un senso al lungo processo della storia.
Non intendiamo proseguire qui il difficile e vasto dibattito sul problema della temporalità, sul tema del corpo umano e della sua trasformazione e su quello del mondo naturale inteso come protesi sempre più sviluppata della società; ci limiteremo ad enunciare i nodi principali che, sotto forma di ipotesi, vengono esposti nel presente saggio.
In primo luogo si studia la costituzione storica e sociale della vita umana, cercando la temporalità interna della sua trasformazione, con una posizione, pertanto, ormai lontana da quella che ammette una successione lineare - “uno accanto all’altro” - degli avvenimenti. Quindi si prende in esame il coesistere, su uno stesso scenario storico, di generazioni nate in momenti differenti, i cui paesaggi di formazione, esperienza e progetto non sono omogenei. La dialettica generazionale, cioè la lotta per il controllo dello spazio sociale centrale, si svolge tra accumulazioni temporali in cui prevale rispettivamente il passato, il presente od il futuro, rappresentate da generazioni di differente età. Sono proprio i rispettivi paesaggi - con il loro caratteristico sostrato di credenze - a spingere le diverse generazioni ad agire nel mondo in modi diversi. Ma il fatto che la morte e la nascita delle generazioni sia un fatto biologico non ci consente di biologizzarne la dialettica. Per questo la concezione ingenua delle generazioni, secondo cui “i giovani sono rivoluzionari, quelli di mezza età diventano conservatori ed i più vecchi reazionari”, trova in numerose analisi storiche forti smentite; non prenderle in considerazione ci condurrebbe a un nuovo mito naturalista, il cui correlato è la glorificazione della gioventù. Ciò che definisce il segno della dialettica generazionale in ciascun momento storico è il progetto di trasformazione o conservazione che ciascuna generazione lancia verso il futuro. E’ poi ovvio che sono più di tre le generazioni che coesistono su uno stesso scenario storico; ma solo quelle centrali e contigue e non quelle che esistono “in compresenza”, cioè i bambini e gli anziani, risultano protagoniste del dramma generazionale. Ma poiché tutta la struttura del momento storico è in trasformazione, il segno di tale momento cambia allorché i bambini entrano nella frangia giovanile mentre coloro che sono in età matura si spostano verso la vecchiaia. Questo continuum storico ci mostra la temporalità in azione e ci fa comprendere come gli esseri umani siano i protagonisti della loro storia.
In conclusione l’aver compreso il funzionamento della temporalità ci consente di estrarre da queste Discussioni storiologiche alcuni elementi che, insieme a quelli studiati in Psicologia dell’immagine relativamente al tema dello spazio di rappresentazione, ci permetteranno forse di dare fondamento ad una completa teoria dell’azione.
Questo è tutto. Grazie.
Edizione originale
Contribucciones al Pensamiento viene pubblicato in Argentina per la prima volta in Argentina nel 1990 dalla Casa Editrice Planeta. Ne esistono poi edizioni in lingua originale curate da Plaza y Valdés in Messico (1990), da Virtual Edicciones in Cile (2013) e da Ediciones León Alado Spagna (2013), Editorial Beta Hydri, Bolivia (2013). Il libro è pubblicato in catalano da Ediciones León Alado (2013), in russo da Vesna (2015) e in tedesco da Uzielli Verlag (1995)
Traduzioni
Il libro è tradotto in catalano, francese, inglese, italiano, russo, tedesco.
Edizioni italiane
Il libro ha avuto, a partire dal 1997, tre edizioni a cura della Multimage inclusa l'ultima del 2014 in formato e-pub; in queste edizioni si conta anche quella delle Opere Complete, Vol. I